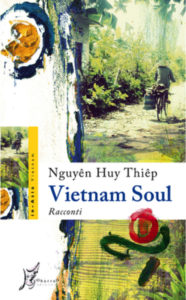 In tutti i paesi a rapido sviluppo c’è una forte tensione tra il mondo rurale e la dimensione urbana. La tensione è dinamismo, commedia e tragedia, è vita in tutte le sue sfaccettature. Nguyên Huy Thiêp (premio Nonino 2008) è il più noto e premiato scrittore vietnamita contemporaneo, e in questa raccolta di racconti (magistralmente tradotta da Tran Tu Quan) regala al lettore piccole e grandi storie di una varia umanità alle prese con i successi, le miserie, le contraddizioni del Vietnam dei giorni nostri. Il suo racconto è antiepico, cosa che infastidì il regime dopo la pubblicazione de “Il generale in pensione”: non ci sono eroi tra i personaggi che animano le pagine, ma persone illuminate dalla dignità richiesta per affrontare l’esistenza quotidiana.
In tutti i paesi a rapido sviluppo c’è una forte tensione tra il mondo rurale e la dimensione urbana. La tensione è dinamismo, commedia e tragedia, è vita in tutte le sue sfaccettature. Nguyên Huy Thiêp (premio Nonino 2008) è il più noto e premiato scrittore vietnamita contemporaneo, e in questa raccolta di racconti (magistralmente tradotta da Tran Tu Quan) regala al lettore piccole e grandi storie di una varia umanità alle prese con i successi, le miserie, le contraddizioni del Vietnam dei giorni nostri. Il suo racconto è antiepico, cosa che infastidì il regime dopo la pubblicazione de “Il generale in pensione”: non ci sono eroi tra i personaggi che animano le pagine, ma persone illuminate dalla dignità richiesta per affrontare l’esistenza quotidiana.
Nella prosa di Nguyên Huy Thiêp c’è nostalgia, certamente. La nostalgia di un mondo perduto, in cui la povertà diffusa si accompagnava però alla saldezza dei legami comunitari, e alla consapevolezza dei valori di condivisione, è tanto più viva quanto più la vita urbana recide legami famigliari consolidati, e induce freneticamente alla ricerca di un successo individuale spesso illusorio: “Non ricordo nemmeno come e quando mi inserii nella vita cittadina. Crebbi a poco a poco, preso dalla smania di correre dietro alle cose effimere” (p. 87). Un sentimento di disincanto e di delusione pervade il racconto quando entrano in scena i contadini, chini sui campi allagati o intenti a disboscare l’intricata giungla: “Gli abitanti delle città e quelli che hanno studiato, come noi, hanno commesso tante colpe nei loro confronti. Li abbiamo distrutti con i nostri piaceri materiali, con l’educazione e la falsa scienza, molestati con le leggi, imbrogliati nei sentimenti, sfruttati fino al midollo, li abbiamo schiacciati con le sovrastrutture, con gli incartamenti della burocrazia e i concetti della civilizzazione… mi capisci? Il mio cuore sanguina per la tristezza” (p. 106).
C’è la corruzione dell’anima. Il capitalismo ha trasformato la società vietnamita e inaridito le coscienze, ponendo il denaro al centro di ogni discorso pubblico e privato: “Che cosa sono i soldi?” Khiem spiegò: “Il nostro Re” (p. 59). La ricchezza (spesso più sognata, agognata e illusoria che realmente ottenuta) diventa il metro di paragone con cui offuscare ogni narrazione che richieda attenzione, approfondimento, concentrazione: “La filosofia è un lusso per secchioni. Hai visto la collana di plastica al collo della cognata Sinh? Quella è filosofia” (p. 43). Sembra quasi che le comunità abbiano perso il senso dello stare insieme, ed è per questo che ritorna con prepotenza l’esigenza di un sentimento morale, come sembra dire una voce fuori dal coro: “I principi della morale sono sempre semplici, ingenui, ridicoli e persino ingannevoli. Il peggio è che sono giusti, perché sono necessari. Sono le catene che portiamo al collo per conservare la nostra identità. Se così non fosse, tutto sarebbe privo di senso…” (p. 140).
C’è la morte, onnipresente. Arriva quando meno te l’aspetti, a oscurare un momento di gioia, una giornata di sole, un abbraccio tra parenti, un amore appena sbocciato. A volte arriva per mano dell’uomo, per dolo o colpa, a volta è la natura che si fa matrigna. C’è consapevolezza della fragilità della condizione umana: “Nella vita ci sarà sempre da combattere la fame e il freddo che ci perseguitano senza pietà: non contano né principi morali, né l’amore per il prossimo” (p. 70). Ma la morte non è mai senza speranza, appare come la condizione per rendere possibile la vita, e potere assaporare il gusto per i piccoli momenti di ogni giorno, per nulla scontati. La morte non fa paura, perché è una certezza – non una possibilità – e di certo non si può vivere nella paura: “Continua a suonare per rallegrare il cuore,/ perché il destino è già scritto:/ qual è l’aquilone cui, almeno una volta,/ non si spezza la corda?” (p. 93).
E infatti, infine, c’è vita. Dopo avere versato le necessarie lacrime, si riparte dal banchetto per la morte del defunto, si accendono gli incensi agli avi, e altra vita scorre davanti ai nostri occhi, come ondeggianti barche sul fiume, come rami al vento della foresta, come la corsa di un bambino verso le braccia della mamma. A tratti le pagine sfiorano il realismo magico della letteratura sudamericana. C’è poesia nella tragedia, c’è levità nei momenti peggiori, c’è amore nel dolore. Forse non è un caso che a un lettore non specialista il paio di racconti che attingono alla storia più antica del Vietnam sembrino meno accattivanti degli altri, poiché l’autore dà il meglio di sé quando il paese diventa quasi una scusa per celebrare il nostro essere uomini, donne, bambini, alle prese con un mondo in rapida trasformazione e allo stesso tempo ancora uguale a mille anni fa, perché immutabili sono in fondo la nostra necessità di sopravvivere, lo stesso desiderio di esprimere i nostri sentimenti, la nostra ansia di dare un senso ai nostri giorni. In altre parole, il Vietnam, così centrale nei racconti da sembrarne il vero protagonista, quasi si trasfigura in un potentissimo, affascinante e luminoso inno alla vita: “Questo bicchiere lo dedico alla vita, il cui contenuto è dolce e al tempo stesso aspro. Chi di noi accetta la vita, è invitato ad alzare il bicchiere. La vita, anche quando è crudele, è comunque meravigliosa” (p. 64). Finché, naturalmente, morte non ci separi.
“Il Gruppo dei BRICS, sempre più variegato, non appare in grado di intraprendere azioni concrete ed efficaci per migliorare la governance mondiale, piuttosto segnala... Read More


Copyright © 2024. Torino World Affairs Institute All rights reserved
