Michael Vatikiotis, Blood and Silk: Power and Conflict in Southeast Asia, Londra: Weidenfeld & Nicolson, 2017.
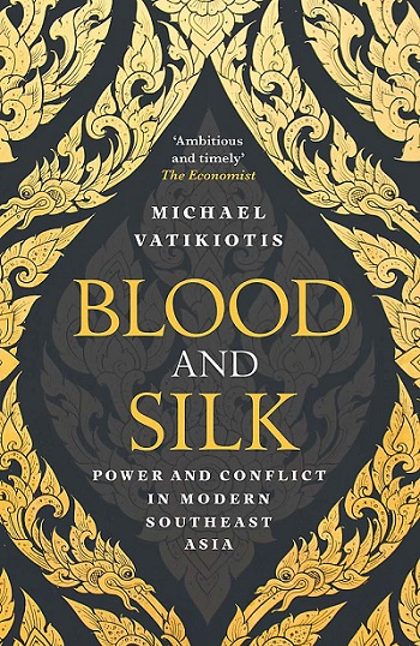
Michael Vatikiotis sbarca la prima volta in Asia sud-orientale nel 1979, all’aeroporto di Bangkok, per svolgere una ricerca all’interno del percorso universitario presso la britannica School of Oriental and African Studies. Tornato a Londra, prosegue gli studi di dottorato dedicandosi all’Indonesia. Viene assunto alla BBC World Service, per cui diventa il corrispondente da Giacarta nel 1987, dove rimane per cinque anni, lavorando anche per la storica testata Far Eastern Economic Review, ora defunta, rischiando anche l’espulsione. Quindi viene trasferito a Kuala Lumpur, e nel 1994 ritorna in Thailandia, chiudendo a Bangkok la sua carriera giornalistica. Accetta l’invito di un amico e apre a Singapore l’ufficio regionale del Centre for Humanitarian Dialogue di Ginevra, dedicandosi alla mediazione dei conflitti nella regione. Blood and Silk è frutto di questa ultradecennale esperienza nel Sud-Est asiatico.
Il volume è allo stesso tempo un memoir personale, un libro della recente storia politica dell’Asia sud-orientale, e un grande reportage sui problemi cruciali che affliggono la regione, frutto di un’eredità coloniale e postcoloniale che viene da lontano: la concezione religiosa del potere personificato da re-divinità, la presenza di élite ristrette che riescono a difendere e mantenere nel tempo salda autorità e immense ricchezze, la violenza politica perpetuata contro la popolazione inerme, una democrazia spesso più formale che reale, i conflitti etnici interni, la corruzione diffusa, l’ascesa dell’Islam fondamentalista.
Vatikiotis lascia trasparire, in molti passaggi, una sincera delusione per avere visto le promesse dello sviluppo economico e della transizione politica in molti stati (le Filippine di Corazón Aquino dopo la fine della dittatura di Ferdinando Marcos, l’Indonesia del dopo-Suharto) infrangersi contro i muri della storia, come se alcune caratteristiche di questi Stati sopravvivessero ai cambiamenti di leadership e di regimi. Per esempio (p. 72), il re birmano Mindon Min, appresa la notizia che nelle elezioni parlamentari inglesi del 1874 William Ewart Gladstone aveva perso la carica di primo ministro a favore di Benjamin Disraeli, commentò che il “povero” Disraeli doveva certamente essere in prigione. L’autore, sconsolato, osserva: “Proprio come allora, il potere nelle società contemporanee del Sud-Est asiatico è un attributo assoluto: o l’hai o non l’hai. E la tua vita ha molto meno valore se non l’hai”. Chi detiene il potere, quindi, se lo tiene molto stretto ed è disposto a difenderlo ricorrendo alla forza: perciò i militari continuano a rivestire un ruolo essenziale e, spesso, invasivo della sfera civile (come in Myanmar, o in Thailandia) nei governi della regione. A volte la vita di centinaia o migliaia di persone viene tranquillamente sacrificata come se liberarsi fisicamente degli individui fosse poco più che una semplice scocciatura a cui non dare peso: nel libro le pagine più amare sono sicuramente quelle dedicate a una lunga serie di rivolte finite nella repressione indiscriminata, e con la cui memoria spesso gli Stati non riescono a fare i conti. Le pagine, in effetti, sono più rosse di sangue (blood) che di seta (silk).
C’è spazio anche per il racconto dello sviluppo economico tumultuoso degli anni Novanta, grazie all’arrivo di ingenti capitali esteri dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall’Europa, ma anche per merito di intere famiglie imprenditoriali di origine cinese, che cominciano ad approfittare dell’apertura al mercato internazionale della Repubblica popolare cinese. Tra grattacieli spettacolari, ingorghi di traffico mai visti prima, frotte di consulenti, finanzieri e manager, le economie crescono, ma non riescono a creare un benessere veramente diffuso: si accrescono le disuguaglianze, il divario tra città e campagna è impressionante, la corruzione rafforza meccanismi clientelari interni alle (solite) élite. Ci sono echi del fastidio con cui Tiziano Terzani raccontò, tornato dopo anni in una irriconoscibile Singapore, di volerla abbandonare al più presto, poiché ai suoi occhi aveva perduto il fascino esotico dei suoi primi anni di permanenza in una città stato non ancora modernizzata. Mentre in Terzani c’era però forse più insofferenza per una direzione dello sviluppo che il noto giornalista e scrittore riteneva sbagliata, qui invece l’autore sembra volere concedere una chance alla crescita economica capitalistica come strumento di riduzione della povertà (a tratti estrema), salvo poi dovere constatare che permangono miseria e precarietà: la delusione, paradossalmente, è ancora più amara. Come dargli torto? Leggiamo che, nelle Filippine, la ricchezza totale dei venticinque più ricchi è equivalente al reddito aggregato dei settanta milioni più poveri (dati 2012). Dal 2010 al 2015, la ricchezza dei dieci filippini più ricchi è triplicata da 14 miliardi di dollari a 45, mentre nel frattempo in media il salario giornaliero minimo cresceva solamente dell’8,8% (p. 168).
Non ci si deve stupire, quindi, se le Filippine registrano una tra le più datate insurrezioni comuniste al mondo. In un intreccio di rivendicazioni economiche, politiche e identitarie, peraltro, la regione registra innumerevoli conflitti irrisolti, spesso dovuti a sciagurate politiche coloniali di suddivisione dei confini e di controlli dei territori. Come se non bastasse, su ciò si innesta la diffusione di un Islam radicale vicino alla corrente wahhabita sostenuta dall’Arabia Saudita, così nuovo e diverso dall’Islam “tropicale” descritto da Lee Kuan Yew, il padre dell’indipendenza di Singapore. Persino nella democratica e tollerante Indonesia, ora, la questione religiosa è abilmente sfruttata dai partiti politici in cerca di facili consensi.
Molto denso e intenso, il testo ha il pregio di offrire un quadro tematico trasversale ai singoli Paesi, offrendo a chi legge la possibilità di comprendere appieno le caratteristiche di fondo che accomunano gli Stati del Sud-Est asiatico. L’impressione che se ne ricava è quella di società in cui le élite si accontentino di permettere alle popolazioni di vivere una vita (in media) moderatamente decorosa, purché non si illudano di contrastare e contestare la ricchezza e il potere concentrati nelle mani dei (soliti) pochi noti, tra loro avviluppati in una complessa rete clientelare. Sembra quasi che le vecchie corti reali siano rinate in nuova forma, e si disinteressino – oggi come allora – di offrire una risposta alle legittime aspirazioni, richieste, preoccupazioni della gente comune che si trova in un rapporto subordinato di sudditanza, e non egualitario basato sul concetto (occidentale?) di cittadinanza. Forse è un’osservazione che ricaviamo perché il volume nasconde sottotraccia (e involontariamente) un approccio orientalista? Il lettore potrà giudicare da sé, ma di certo troverà tra le sue mani un testo ben scritto, colto e raffinato, un prodotto della miglior palestra sul campo che ha fatto della BBC un’istituzione del giornalismo mondiale, e un frutto del Regno Unito di fine XX secolo che sapeva accogliere, formare e integrare nei valori democratici anche autori “levantini” (per sua stessa definizione) come Vatikiotis: un’Inghilterra – in questo senso – di cui a volte si prova un’immensa nostalgia, come della giovinezza carica di ideali lasciata irrimediabilmente alle spalle.
—
“Il Gruppo dei BRICS, sempre più variegato, non appare in grado di intraprendere azioni concrete ed efficaci per migliorare la governance mondiale, piuttosto segnala... Read More


Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved
