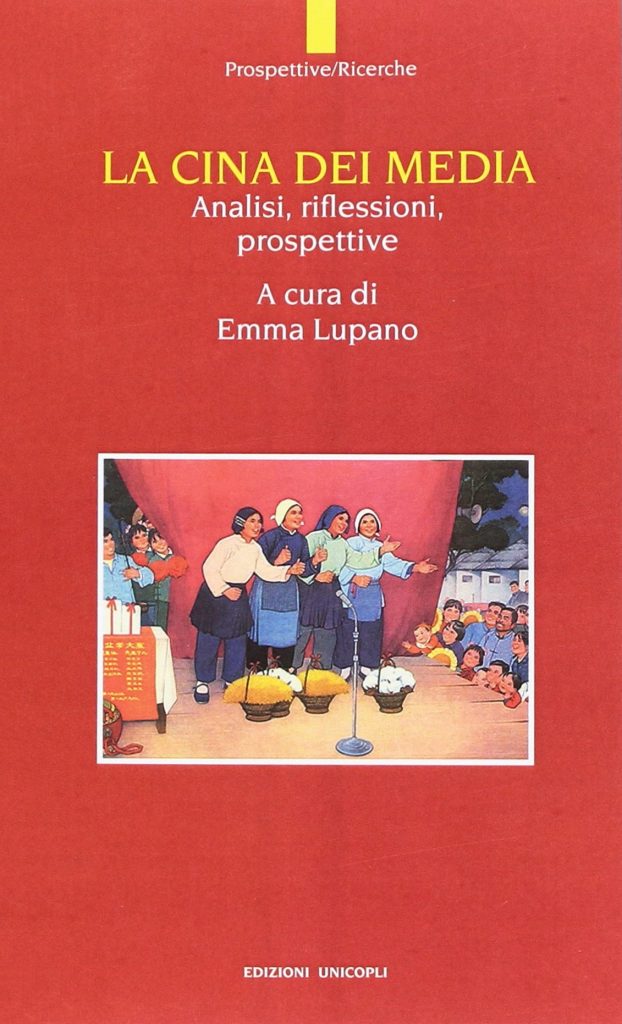 Emma Lupano (a cura di), La Cina dei media. Analisi, riflessioni, prospettive, Milano: Unicopli, 2016.
Emma Lupano (a cura di), La Cina dei media. Analisi, riflessioni, prospettive, Milano: Unicopli, 2016.
Quanto complesso è il mondo della comunicazione nella Cina contemporanea? Può il ricercatore che si occupa di questi temi dare conto delle mille sfaccettature di uno scenario – quello dei media nella Repubblica popolare – in così rapida trasformazione? Il volume collettaneo curato dalla sinologa Emma Lupano (membro del comitato di redazione di OrizzonteCina) che presentiamo ai lettori in questo numero è la risposta positiva a questa seconda domanda. Come ricorda Alessandra Lavagnino nella premessa, ciò che accomuna il lavoro degli autori dei nove capitoli del testo è il “costante ricorso alle fonti in cinese”, premessa per “la costruzione di un solido discorso critico”, all’interno di uno specifico percorso di ricerca e didattica da tempo avviato dall’Università degli Studi di Milano.
Mentre all’osservatore occidentale superficiale la Cina dei media appare come un mondo in bianco e nero – dove l’onnipresente censura di un governo autoritario è fronteggiata da pochi coraggiosi giornalisti dissidenti – il lettore attento di La Cina dei media troverà davanti a sé uno scenario molto più articolato, dove interstizi di libertà fanno capolino tra le parole della propaganda ufficiale, e al contempo – viceversa – forme più sottili di controllo del pensiero di massa si affidano a strumenti apparentemente rispondenti a logiche di mercato, o di servizio al cittadino-utente (e quindi, più dominate dalla libera scelta). Come il particolare rapporto tra stato e mercato nella Cina degli ultimi decenni ha generato una crescita economica sorprendente anche se spesso inefficiente, anche nei media l’intricata dinamica tra discorso ufficiale e lingua comune, tra media di stato e media “indipendenti”, ha dato vita a una tensione creatrice in cui evoluzione e involuzione coabitano, si confrontano, lottano, si influenzano a vicenda, misurando gli spazi disponibili per ottenere i rispettivi obiettivi in modo pacifico.
Illuminante a questo riguardo è il capitolo introduttivo di Tanina Zappone (Università di Torino), che illustra la dualità della comunicazione del governo sul web 2.0 cinese. Da un lato, esso ha lanciato campagne politiche per “purificare il web”, appellandosi “alla responsabilità sociale dei microblogger più influenti, affinché si instradino lungo il “giusto binario” (zhengque guidao, 正确轨道), diffondano “energie positive” zhengneng liang, 正能量) e rispettino le “sette linee di base” (qitiao dixian, 七条底线), un decalogo di principi guida volutamente vaghi, mirati a inibire la multipolarità della comunicazione online e indurre forme preventive di autocensura” (p. 15). Dall’altro, la comunicazione digitale per il governo è uno strumento di acquisizione del consenso, in cui è attivata una (nuova nelle forme, ma già ben conosciuta nella sostanza) “supervisione dell’opinione pubblica” che permette al governo di intercettare gli umori del Paese e di intervenire laddove necessario, lanciando una controffensiva mediatica, oppure agendo con strumenti amministrativi (di service-delivery) per rispondere alle fondate richieste di un’azione dei poteri pubblici più incisiva, più in linea con i bisogni dei cittadini. A questo riguardo Bettina Mottura (Università di Milano) analizza il discorso ufficiale sulla diffusione dell’informazione in Cina, rivelando come le esigenze di trasparenza abbiano cambiato l’approccio stesso dell’amministrazione al modo in cui essa interagisce con i cittadini. Del resto il governo deve convivere con forme di giornalismo indipendente (“we media”) in cui i cittadini diventano essi stessi produttori e divulgatori di informazioni – un fenomeno descritto da Alice Giusto (Università di Pechino) nel suo contributo, che si conclude con la certezza che queste forme siano già una rivoluzione per il sistema dell’informazione in Cina. Lo stesso desiderio di libertà espressiva è mostrato dai giornalisti intervistati da Emma Lupano (Università di Milano), e le cui dichiarazioni formano l’oggetto dello studio linguistico del suo capitolo: questi professionisti, infatti, fanno spesso ricorso al linguaggio quotidiano, più libero e meno impostato, utilizzando invece molto raramente “locuzioni provenienti dal linguaggio ufficiale”.
Deng Xiaoping sosteneva che la Cina aveva bisogno di una “modernizzazione senza occidentalizzazione”, e che quindi le idee e le tecniche occidentali dovevano essere assorbite ma non assimilate, bensì interpretate e adeguate alle specifiche caratteristiche cinesi. La flessibilità della lingua cinese in quest’esercizio è di grande aiuto, come illustra Natalia Riva (Università di Cagliari) che nel secondo capitolo si occupa del concetto di soft power. Il concetto fu creato da un docente americano, Joseph Nye, che ha riflettuto sulla capacità di uno stato di convincere altri stati, inducendoli (senza ricorrere a strumenti militari o economici) a mettere in atto comportamenti in linea con i suoi obiettivi, interessi, desideri. Il concetto di soft power che si è affermato in Cina è quello di “soft power culturale” (wenhua ruan shili, 文化软实力), scevro delle considerazioni di potere e di egemonia tipico del discorso occidentale, e portatore invece i valori della millenaria civiltà cinese. Un’idea di matrice occidentale viene quindi rielaborata per rafforzare gli elementi neo-confuciani a cui la dirigenza di Xi Jinping ha attinto – in un’ottica nazionalista – negli scorsi anni. Pechino sapientemente utilizza il richiamo alla specificità culturale e linguistica cinese per distanziarsi dall’Occidente e per trasmettere al pubblico “l’immagine di una Cina forte e rispettata internazionalmente, un’immagine in sintonia con la retorica della ‘rinascita nazionale’ e con le esigenze di legittimazione del partito” (p. 57). Sono parole di Simone Dossi (Università di Milano, e anch’egli membro del Comitato di redazione di OrizzonteCina), che nel suo contributo analizza gli articoli pubblicati dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa ufficiale, durante il vertice dell’Apec (Asia-Pacific Economic Community) che si tenne a Pechino nel novembre 2014. Dossi scopre che il quotidiano approfitta del vertice Apec per veicolare l’applicabilità all’Asia-Pacifico dell’idea confuciana della “grande famiglia”, “fondato non già sull’informalità e sull’egualitarismo delle relazioni, bensì sulla rigorosa distinzione dei ruoli attribuito a ciascun membro della famiglia” (p. 63). L’Asia diventa quindi una regione in cui la Cina, forte dei suoi successi, è una madre benevola nei confronti dei vicini, preoccupata dal raggiungimento di comune progresso, collaborazione, armonia.
Questa differenza di approccio emerge anche nei regimi regolativi internazionali (Gianluigi Negro, dell’Università della Svizzera Italiana, racconta come la Cina stia cercando di costruire un sistema di governance globale della rete parzialmente diverso da quello oggi in uso), e in curiosi aspetti di costume (assai divertente è apprendere come “il cibo nei teleschermi” di MasterChef e dintorni è presentato diversamente in Cina e in Occidente, come mostra Valeria Varriano, dell’Università di Napoli “L’Orientale”). Nella sua varietà e ricchezza di contributi, accomunati da un approccio comune allo studio della Cina contemporanea, La Cina dei media mantiene la promessa contenuta nel sottotitolo, offrendo interessanti spunti di riflessione e approfondimento del mondo mediatico (non solo cinese) che verrà, pericolosamente in bilico tra civica partecipazione orizzontale e inquietanti scenari orwelliani.
I libri recensiti in questa rubrica possono essere acquistati presso la Libreria Bodoni di via Carlo Alberto, 41, Torino.
“Il Gruppo dei BRICS, sempre più variegato, non appare in grado di intraprendere azioni concrete ed efficaci per migliorare la governance mondiale, piuttosto segnala... Read More


Copyright © 2025. Torino World Affairs Institute All rights reserved
